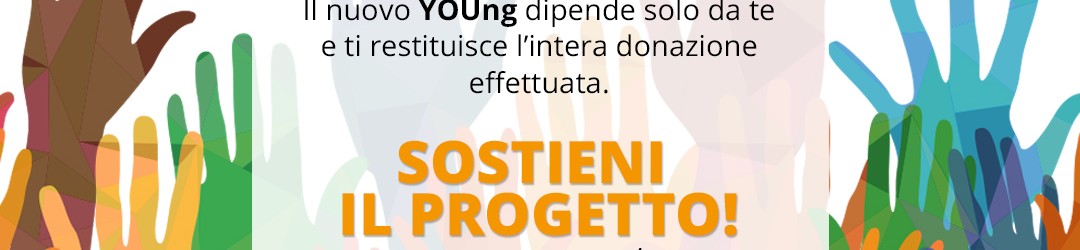Odori e reminiscenza: 3 paragrafi sulla memoria olfattiva
Quando di un antico passato non sussiste niente, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, soli, più fragili ma più intensi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore restano ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sulla rovina di tutto il resto, a reggere, senza piegarsi, sulla loro gocciolina quasi impalpabile, l’immenso edificio del ricordo. Marcel Proust
L’olfatto: il senso privilegiato dalla memoria
Quante volte abbiamo sperimentato, per lo più inconsapevolmente, l’incredibile capacità degli odori di risvegliare in un istante e d’improvviso un’esperienza passata e radicata nel fondo della nostra memoria? Come una scintilla, un certo profumo casualmente risentito a distanza di anni può immediatamente ridestare in noi un’ondata di ricordi sopiti, lasciando riaffiorare, con dovizia di
particolari, esperienze della nostra esistenza passata che ci sembravano definitivamente rimosse.
L’odore è infatti il più grande alleato dei ricordi: ci permette di viaggiare nel tempo e perciò fa sì che l’olfatto venga eletto a senso privilegiato dalla memoria. Un odore o un profumo già sentiti hanno l’impareggiabile potere di rimaterializzare anche i nostri ricordi intimi, di renderci presenti
eventi lontani, riportandoci improvvisamente a una scena dell’infanzia, a un paesaggio o a un episodio della nostra vita passata – rievocato con ricchezza di particolari attraverso una semplice zaffata – e innescando, a seconda dei casi, la nostra nostalgia, la nostra malinconia, la nostra gioia o la nostra tristezza. Nessun altro dato sensoriale è altrettanto memorabile di un odore, altrettanto resistente al logorio del tempo, altrettanto evocatore del passato e altrettanto capace di sollecitare tutti gli altri sensi. La tenacia dei ricordi olfattivi e la carica emotiva che li accompagna ci spiegano, meglio di ogni altra causa, la fortuna letteraria dell’olfatto e degli odori – denigrati dai filosofi e dagli scienziati ma celebrati da scrittori quali Balzac, Baudelaire, Flaubert, Wilde, D’Annunzio, Proust, Gadda, Calvino, Süskind. Ancorché fuggevole e ineffabile, l’odore è, come dice Gaston Bachelard nella Poetica della rêverie, quel «particolare immenso» (1960: 153) che in un istante ci guida al cuore delle cose, nell’intimità delle altre persone e nei recessi, spesso inconfessati, del nostro vissuto. Questo fenomeno, comune e speciale al tempo stesso, è noto come ‘sindrome di Proust’, perché, in una famosa pagina della Recherche, lo scrittore evoca un episodio della sua infanzia legato al sapore e all’odore di un pezzetto di madeleine (1913: 133). Gli odori sanno dunque attivare la memoria episodica: cioè quella forma di memoria a lungo termine che custodisce i ricordi autobiografici costitutivi della nostra identità.
Al di là degli aneddoti e dei racconti letterari, le ricerche scientifiche degli ultimi decenni attestano la singolarità cognitiva della memoria olfattiva – che tuttavia non cessa di essere una «memoria dimenticata» (Roncato, Zucco 1993: 120) entro una letteratura psicologica ancora troppo concentrata su immagini e suoni – rispetto alle altre memorie sensoriali (Engen, 1982, 1987; Herz, Engen 1996; Schab 1991; Schab, Crowder 1995; Lehrner et al. 1999; Zucco 2000; Candau 2001, 2004): la sua persistenza, la sua tonalità edonistica, il suo legame con il contesto percettivo e poi ancora l’invadenza degli odori, cioè la loro tendenza a imporsi anche a prescindere dalla nostra attenzione volontaria. Non a caso, Kant definiva l’olfatto il senso «contrario alla libertà» (1798: 2 578-9), visto che – ci piaccia o no – siamo costretti ad annusare olezzi di ogni genere. Mentre affievolisce i ricordi visivi e verbali, il passare del tempo non sembra incidere sugli stimoli olfattivi: la speciale codifica olistica (non isolata dal contesto della sensazione d’origine) e la caratteristica multisensorialità rende infatti particolarmente resistenti all’oblio questi stimoli, che pure vengono immagazzinati in una forma per lo più accidentale e irriflessa. Un ricordo olfattivo non è mai puramente olfattivo, perché un odore percepito viene memorizzato unitamente al contesto sensoriale ed emozionale in cui è stato esperito. Evocarlo significa pertanto associarlo a una sensazione e rivivere la situazione in cui quel determinato aroma ci ha impressionati. Oggi sappiamo che un ricordo associato a un profumo può, a sua volta, attivare le regioni del cervello sensibili agli odori.
Ad alcuni soggetti è stato chiesto di creare storie o di stabilire comunque legami tra una serie di fotografie raffiguranti oggetti vari e una serie di odori diversi, percepiti contemporaneamente all’osservazione delle foto. La successiva esibizione delle medesime foto, senza la simultanea diffusione degli odori, riattivava la corteccia olfattiva (corteccia piriforme). Questo dato induce a supporre che un ricordo episodico e attraversato da una suggestione multisensoriale (odori, suoni, immagini) non venga immagazzinato in un unico centro cerebrale (l’ippocampo), ma sia distribuito tra aree differenti, così da essere risvegliato anche da un unico canale sensoriale: un meccanismo siffatto potrebbe rendere più flessibile il recupero dei ricordi (Gottfried et al. 2004).
Un’altra caratteristica delle memorie olfattive è il ruolo egemonico della componente sentimentale. Solitamente – ma non sistematicamente – si tratta di ricordi a connotazione positiva, legati ad atmosfere piacevoli, a momenti felici dell’infanzia, delle vacanze, delle scampagnate, delle gite al mare o in montagna e insomma a profumi e aromi delle persone familiari o dei banchetti festivi. E si dà anche il caso curioso di ricordi gradevoli associati a odori di solito giudicati sgradevoli: l’odore del cloro può per esempio richiamare i giochi piacevoli in una piscina (Candau 2001; 2004: 73-4). La frequenza con cui siamo esposti a un odore e la peculiarità dell’odore stesso possono essere fattori non secondari della memoria olfattiva: quanto più un odore è insolito, tanto più alta si fa la probabilità che esso venga associato a un solo ricordo – anche se si tratta del ricordo di un evento occorso una sola volta nella vita. Ma la forza delle memorie olfattive dipende anche dall’importanza che la situazione in cui l’odore è stato percepito ha avuto nei processi di apprendimento di una persona. Le informazioni provenienti dagli odori si conservano stabili nella memoria a lungo termine ed hanno un potente aggancio con la memoria emotiva: di qui lo straordinario potere evocativo e la forte rilevanza affettiva degli odori. Più antiche sono le memorie olfattive, più profonde risulteranno le emozioni che esse risvegliano. La spiegazione di questa proprietà dell’olfatto ci viene dalla biologia: il cervello ‘profumato’ che elabora le informazioni provenienti dal naso coincide, da una parte, con il sistema limbico o cervello viscerale, comprendente l’ippocampo e l’amigdala (le strutture più arcaiche del nostro encefalo, che controllano emozioni, stati d’animo, istinti, appetiti – compreso l’appetito sessuale – e certe operazioni della memoria), dall’altra parte, coincide con alcune aree della neocorteccia frontale.
Tutte queste aree integrano le diverse informazioni sensoriali e conferiscono all’odore una connotazione affettiva, favorendo altresì la conservazione del ricordo (Buck 2000: 625; Brand 2001: 39-40; Holley 1999: 187 ss.). Nuove prove neurofisiologiche della peculiarità della memoria olfattiva emergono poi da una recente ricerca americana: nel bulbo olfattivo, sembrano annidarsi cellule nervose a forma di stella che, pur essendo poco numerose, hanno tuttavia ramificazioni fibrose molto più sviluppate degli altri neuroni e possono dunque esercitare un controllo più deciso sulle altre cellule cerebrali. Un indizio odoroso può così essere amplificato centinaia di volte, risvegliando ricordi sommersi e collegati a vari stati d’animo (Kerr, Belluscio 2006).
La Tenacia e l’inconsapevolezza dei ricordi olfattivi
La singolarità della memoria olfattiva investe non solo l’acquisizione di esperienze passate, ma anche i processi d’apprendimento. Avere, per es., memorizzato una lista di parole in un ambiente soffuso da un determinato odore, faciliterà l’evocazione di quelle parole ogni volta che quel medesimo odore tornerà a sollecitare le nostre narici. Gradevole o sgradevole che sia, un odore può dunque rivelarsi un supporto mnemonico tale da condizionare reazioni e prestazioni. Gli odori neutri o sconosciuti, privi di connotati emotivi, riescono in genere più efficaci, perché sono più prontamente associabili a una nuova situazione (Vroon et al. 1994: 124-25). Diversamente dalla memoria visiva – che, codificando le immagini come un insieme di caratteristiche discrete quali i colori e le forme, fornisce non pochi indizi per un riconoscimento immediato (come nel caso di un paesaggio, di una scena o di un quadro) – la memoria olfattiva archivia gli odori secondo un principio olistico ovvero tramite una percezione globale che obbedisce al principio del tutto-o- niente (Engen 1982: 111). Sfuggenti all’analisi per tratti elementari, gli odori si dimostrano più resistenti alle interferenze retroattive (oblio causato dagli apprendimenti successivi a quello iniziale). Questa particolare procedura di ‘stoccaggio’ degli odori se, da una parte, garantendo ai ricordi olfattivi una loro individualità e una loro reciproca (ancorché relativa) indipendenza, riesce senz’altro vantaggiosa nel recupero a lungo termine, dall’altra parte, si rivela poco funzionale nel recupero a breve termine: l’insufficienza degli indizi utili a facilitare la ricostruzione dell’intero ricordo riduce infatti le prestazioni dei soggetti.
Varie ricerche sperimentali dimostrano peraltro che il recupero a breve termine dei ricordi visivi è favorito dalla pluralità degli indici di riconoscimento, là dove l’interferenza di apprendimenti successivi compromette le performances della memoria visiva nel riconoscimento a lungo termine (si pensi, per es., alla possibilità di confondere due immagini che condividano certi elementi cromatici). Ecco perché la ripetizione di un determinato stimolo favorisce la conservazione dell’immagine visiva, ma non agevola certo la custodia mnestica di una traccia olfattiva. Se la memoria degli odori resiste al processo d’interferenza retroattiva, non altrettanto può dirsi per l’interferenza proattiva: le vecchie associazioni inibirebbero i tentativi di allacciare nuovi legami con gli stessi stimoli. Sicché – spiega lo psicologo Trygg Engen (1982: 166) – i ricordi degli odori (e, fra essi, le idiosincrasie ormai radicate: soprattutto quelle relative al cibo), una volta consolidatisi sono difficilmente modificabili: un aspetto importante della memoria olfattiva, deputata anzitutto a preallarmare l’individuo sull’eventuale ricorso di rischi già sperimentati (per es., gli aromi di certi alimenti dannosi precedentemente ingeriti). Diversi esperimenti sull’apprendimento olfattivo dimostrano poi che l’associazione di un odore con il suo nome e/o con l’immagine della sua fonte migliora significativamente le prestazioni dei soggetti impegnati in un
riconoscimento immediato (infra § 3).
Che la classificazione degli odori sia per lo più fortuita, involontaria e resistente a una rigida codificazione verbale e che l’impronta familiare o piacevole di un odore non influisca sulla memoria a lungo termine e sul riconoscimento degli odori sono aspetti altrettanto rilevanti della memoria olfattiva (Roncato, Zucco 1993: 128-31). Essa peraltro comporta varie funzioni, quali appunto il riconoscimento, l’identificazione e la rievocazione, e prevede, oltre a quelli già segnalati, altri sistemi e sottosistemi mnestici: la memoria semantica (preposta all’individuazione di oggetti o di fenomeni denominabili tramite il linguaggio verbale) e la memoria implicita (relativa ad avvenimenti immagazzinati inconsapevolmente ma tali comunque da influire sulla nostra condotta).
Nella vita quotidiana, accade raramente che un odore venga memorizzato con un preciso atto di volontà: in genere, gli odori si apprendono accidentalmente e involontariamente (Issanchou et al.: 2002). La memoria implicita può (parzialmente) attivarsi anche negli stati di incoscienza profonda, come il coma: è infatti accaduto che un paziente, appena risvegliatosi dal coma, abbia riconosciuto l’odore della saponetta con cui veniva lavato durante la sua lunga incoscienza (Vroon et al. 1994: 118). Gli studi sulla memoria implicita degli odori non sono numerosi, benché le ricerche sull’importanza delle esperienze olfattive in epoca prenatale e postnatale (quando l’odorato è tra i primi sensi ad attivarsi) facciano pensare che l’apprendimento olfattivo implicito e inconsapevole sia molto precoce e orienti prestissimo le nostre preferenze affettive e alimentari (cfr. Schaal, Hertling: 1981-2000; Marlier, Schaal: 1997; Schaal et al.: 1998; Schaal et al.: 2002). Non a caso, i ricordi olfattivi risalenti alla prima infanzia e addirittura alla vita prenatale riaffiorano più facilmente di altri ricordi e sono i più capaci di suscitare emozioni gradevoli (Candau 2001). La potenza dei ricordi olfattivi ha trovato perciò un’applicazione concreta nella cosiddetta olfattoterapia. Sperimentato di recente in Francia, questo trattamento dolce intende aiutare pazienti
che abbiano subito traumi cranici o che siano emersi da uno stato comatoso a ritrovare la memoria, la parola e lo slancio vitale, annusando odori evocativi (quello del cioccolato, ma anche quello dell’erba appena tagliata o quello della brezza marina) o diffondendo aromi collegabili a un preciso momento della giornata: l’aroma mattutino del caffé e del pane appena tostato, l’aroma serale della tisana che induce al sonno (Le Guérer: 2004).
Riconoscere, identificare e immaginare un profumo
Tanto nel mondo animale quanto nel mondo umano, l’atto dell’annusare non rappresenta soltanto una funzione biologica fondamentale, ma è anche uno strumento cognitivo prezioso e incomparabile. Collettore e veicolo di informazioni evolutivamente funzionali all’adattamento, la memoria olfattiva è così potente e durevole da impedirci di modificare l’avversione ormai radicata
per gli alimenti di cui abbiamo sperimentato la tossicità o che abbiamo comunque associato a un’esperienza negativa (Herz, Eich 1995: 166). Come s’è detto, il riconoscimento degli odori a lungo termine è più pronto e più sicuro di quello a breve termine: nelle prove di riconoscimento immediato (quando l’intervallo fra l’apprendimento dell’odore e la prova di riconoscimento è di
pochi secondi o minuti), la percentuale di odori correttamente distinti non oltrepassa il 70-80%, a fronte di risultati prossimi al 100% registrabili in prove simili di riconoscimento riferite alle immagini o ai suoni. Per contro, mentre le memorizzazioni olfattive dei soggetti rimangono piuttosto stabili anche a distanza di un mese o di un anno, le memorizzazioni ottiche e acustiche non hanno la stessa tenuta (Engen, Ross: 1973; Holley: 1999: 143-44; Roncato, Zucco 1993: 128-131; Zucco 2000: 59, 2007: 155-56). È stato dimostrato in vari modi che se un odore viene ricordato entro le ventiquattro ore dalla sua percezione, la sua traccia mnestica si manterrà ancora dopo un mese e finanche dopo un anno (Schab, Cain: 1991).
Le ricerche attestano che gli esseri umani, ancorché siano capaci di individuare un odore anche da un semplice indizio, spesso non dimostrano altrettanta prontezza identificativa davanti ad aromi facilmente riconoscibili. Identificare un odore significa infatti riconoscerlo, rendersi conto cioè di averlo già sentito, ricondurlo a una classe ed estrarre contestualmente dalla memoria semantica un’etichettatura pertinente con cui designarlo: un processo cognitivo cui le donne sembrano in genere più inclini degli uomini, probabilmente per fattori ormonali, cerebrali (il cervello femminile vanta, a quanto pare, una migliore interazione tra i due emisferi) e sociali (la
scelta e la preparazione degli alimenti e l’esperienza cosmetica, tenendo le donne più frequentemente a contatto con gli aromi, con i profumi e con gli unguenti, ne rende più affilata la sensibilità olfattiva; Engen 1982: 156-57; Zucco 1988: 49-51; Brand 2001: 57-59; Vroon et al. 1994: 98-101). Spesso siamo incapaci di identificare persino un profumo familiare come quello di una rosa, quando la rosa non è presente. Un dato che stride con la tenacia della memoria olfattiva è infatti il suo sottrarsi alla verbalizzazione, la sua ostinata alinguisticità. Trasporre un odore in parole è un compito cognitivo complicato peraltro dalla mancanza di un adeguato sistema di classificazione entro cui ordinare gli odori e di un lessico olfattivo saldamente condiviso. Persino le fragranze più quotidiane, come quella del caffé o quella della cioccolata, risultano difficilmente descrivibili.
Ancorché impreciso e instabile, il vocabolario degli odori non è tuttavia povero, dal momento che può attingere alla ricca nomenclatura delle fonti odorose e alle risorse proprie della creatività linguistica: similitudini, metafore, metonimie, perifrasi. Una sua caratteristica ineliminabile è però
la notevole variazione definitoria interindividuale: per es., alcune persone definiscono l’odore di eugenolo come ‘odore del chiodo di garofano’, altre persone lo definiscono come ‘odore del dentista’, altre ancora come ‘odore speziato o chimico’ (Rouby, Sicard 1997: 61-2). Non pochi studi attestano che le performances dei soggetti impegnati nella comparazione o nella scelta multipla – dove occorre identificare odoranti presentati contemporaneamente – sono migliori di quelle dei soggetti impegnati nell’identificazione libera. Altrettanto efficaci sono le risposte dei soggetti il cui compito identificativo viene facilitato attraverso la presentazione di odoranti familiari oppure di odoranti sui cui vengono offerti suggerimenti sensoriali (per es. l’associazione con un’immagine della loro fonte) o linguistici (per es. l’indicazione dei nomi) o, insieme, sensoriali e linguistici (per es. l’associazione con la fonte e, insieme, l’indicazione del nome). A quanto pare, fornire denominazioni alternative riduce lo sforzo impiegato da un individuo nella ricerca di un’etichettatura appropriata (Jehel et al.: 1997; Lyman, McDaniel: 1986; Doty, Shaman, Dann: 1984; Zucco 1988: 49-51; Richardson, Zucco: 1989; Rouby, Sicard: 1997; Brand 2001: 63-64).
Questo fenomeno è chiarito dalla cosiddetta «teoria del doppio codice» (Paivio: 1986): la memorizzazione e il recupero delle informazioni si dimostra più funzionale nel caso in cui si disponga di due punti di riferimento tramite una doppia codificazione, semantica (verbale) e anche sensoriale.
Per analogia col cosiddetto fenomeno ‘della punta della lingua’, la resistenza dell’odore alla parola è stata definita ‘fenomeno della punta del naso’: percepiamo un odore che siamo certi di conoscere e tuttavia non siamo in grado di denominarlo o di descriverlo, se non in una forma imprecisa e approssimativa (Harper 1968; Lawless, Engen: 1977; Engen 1982). Questo fenomeno potrebbe trovare una spiegazione nei deboli legami tra il cervello odorante e i centri neocorticali del linguaggio: di fatto, gli odori stimolano soprattutto il cervello viscerale e l’emisfero destro. Ma la distanza tra gli odori e i loro nomi potrebbe dipendere anche dalla scarsa importanza attribuita dalla società moderna (per lo meno in occidente) all’apprendimento olfattivo e alle informazioni forniteci dal naso. Alcune evidenze empiriche invitano tuttavia a una certa cautela: l’addestramento e l’esperienza possono migliorare le prestazioni, come dimostrano i nasi eloquenti di molti professionisti dell’olfatto (sommeliers, profumieri-compositori, etc. – cfr. Cavalieri 2009: 181 ss.). E altri dati sulle esperienze precoci dei bambini comprovano che la capacità di apprendimento dei nomi degli odori tra i 4 e i 17 anni segue un andamento simile a quello osservato negli altri ambiti sensoriali: più scarsa nei bambini, aumenta con l’età e con l’esperienza e, insieme a essa, si
consolida anche la prontezza nel riconoscere gli odori corrispondenti. Associare ripetutamente parole o oggetti ad alcuni odori perfeziona non già la loro capacità di denominazione spontanea, bensì la scelta corretta tra più nomi. Sempre nei bambini, è stato osservato uno scarto tra conoscenza degli odori e capacità di identificarli. La modalità olistica di codifica degli odori, non facilitando l’attribuzione del nome, potrebbe essere la causa della difficoltà nell’identificare un odore. Non è ancora chiaro, tuttavia, quanto incidano sulla qualità delle performances nella denominazione degli odori, prima dei 10-12 anni, da una parte i limiti delle capacità di astrazione e
di simbolizzazione, dall’altra parte, la ridotta dimestichezza con gli odori – e quindi con i loro nomi (Lehrner, Walla 2002; Rouby et al. 1997). Non va d’altronde dimenticato che nel mondo occidentale i bambini non ricevono un’educazione olfattiva paragonabile a quella visiva e musicale: è raro o è casuale che da piccoli veniamo addestrati a riconoscere gli odori e a verbalizzarli.
Un compito cognitivo altrettanto arduo è la capacità di immaginare un odore, cioè di evocarlo in sua assenza, soprattutto se paragonato alla facilità con cui si richiamano immagini e suoni. Se si chiede ad alcune persone di provare ad immaginare un odore, la maggior parte se ne dichiarerà incapace. Sono pochissimi coloro che possono vantare la facoltà di rievocare a piacimento odori noti. In questo caso – si obietta – non si può escludere che di fatto si stia confondendo l’esperienza olfattiva con le rappresentazioni mentali fornite da altri sensi, evocando in realtà l’immagine della fonte dell’odore, il suo nome o altri suoi attributi caratteristici – come per es., nel caso del pane,
l’essere caldo e croccante. La relazione odore-episodio è infatti asimmetrica (Engen: 1987): come s’è detto, un odore ci riporta alla memoria episodi del nostro passato con una certa ricchezza di dettagli, ma la rievocazione di una particolare circostanza non ci permette di rivivere internamente l’esperienza di un odore. Si tratta di un problema non trascurabile, quanto alla sua incidenza sullo statuto cognitivo delle rappresentazioni mnestiche degli odori. Questa difficoltà non sembra però investire i creatori di profumi: se non fossero dotati di una straordinaria immaginazione olfattiva, coniugata a fantasia, talento e genialità, difficilmente essi riuscirebbero ad esercitare il loro mestiere di ‘nasi’ per antonomasia, a comporre cioè note odorose per creare essenze e profumi grazie al loro olfatto allenatissimo. Quando si deve creare un profumo – affermava qualche anno fa Sophia Grojsman, un ‘naso’ di origine russa – «in testa c’è sempre un’immagine: si può addirittura sentire
l’odore degli accordi olfattivi, che sono accordi musicali» (cit. in Ackerman: 1990: 52). La nascita di un profumo presuppone la ricerca mentale di una forma olfattiva che, prima di essere realizzata, va anzitutto immaginata: «il futuro profumo – scrive Maurice Maurin, un ‘naso’ francese – deve essere ‘visualizzato mentalmente’» (2006: 34), ovvero pensato e composto nella mente e questo implica necessariamente la capacità di immaginare la fragranza che si intende ottenere.
Al di là dei dati introspettivi, non esiste purtroppo alcun metodo sperimentale che permetta di valutare con certezza tale fenomeno. Le prove più affidabili a sostegno dell’esistenza di immagini olfattive provengono dalle ricerche sulle allucinazioni, da quelle sui sogni e da alcuni studi di neuro-imaging. Le allucinazioni olfattive sono percezioni endogene abbastanza rare e tuttavia
tipiche, per esempio, della schizofrenia (la percentuale di soggetti schizofrenici che hanno allucinazioni olfattive varia dal 2 al 35%) e di alcune forme di epilessia di origine tumorale o vascolare (Elmes: 1998; Stevenson, Case: 2005). Quanto alle evocazioni oniriche degli odori (assai meno frequenti delle tracce oniriche di immagini visive, uditive, gustative e cenestesiche), i rari studi al riguardo rilevano che nei sogni le immagini olfattive sono meno vivaci di quelle visive ma emotivamente più intense. Indagini condotte con la risonanza magnetica funzionale (MRf) hanno fornito altre evidenze a sostegno della possibilità di una rievocazione mentale di immagini olfattive: soggetti a cui è stato chiesto di immaginare odori familiari hanno mostrato un’attività cerebrale in aree corrispondenti a quelle attivabili in presenza di odori reali. Utilizzando la tomografia a emissione di positroni (PET), alcuni studiosi hanno poi dimostrato che le aree coinvolte nei processi di percezione olfattiva si attivano anche durante l’evocazione, a riprova della coincidenza
neuroanatomica dei siti cerebrali (Levy et al.: 1999, cit. in Holley: 2002: 23-24; Djordjevic et al.: 2005).
Nonostante l’esiguità delle evidenze scientifiche, la scarsa inclinazione degli stimoli olfattivi alla rievocazione cosciente non esclude l’esistenza di una rappresentazione interna del materiale olfattivo. Se così non fosse, sarebbe impossibile persino riconoscere un odore, ricordarlo, applicarvi un’etichetta verbale e, ancora, avere rappresentazioni inesatte di un evento effettivo (percepire un odore con un’intensità superiore a quella reale) o illusioni olfattive (percezioni errate di stimoli reali e falsi allarmi). Il formato delle immagini olfattive resta a tutt’oggi poco chiaro. È indubbio che
l’accesso a queste immagini, in genere involontario, si dimostri invece intenzionale tutte le volte che le nostre facoltà di attenzione, di memoria, di giudizio, di deduzione agiscono nei compiti cognitivi di riconoscimento e specialmente in quelli di identificazione di un odore.
Estratto de ” Il naso intelligente. Che cosa ci dicono gli odori, ” Rosalia Cavalieri
Laterza, Roma-Bari 2009.
Riferimenti bibliografici
Ackerman D., 1990, Storia naturale dei sensi, trad. it. Frassinelli, Milano, 1992.
Bachelard G., 1960, La poetica della rêverie, trad. it. Dedalo Ed., Bari, 1993.
Brand G., 2001, L’olfaction: de la molécule ou comportement, Solal Editions, Marseille.
Buck L.B., 2000, I sensi chimici: olfatto e gusto, in E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T.M. Jessell (a cura di), Principi di neuroscienze, trad. it., 3ª ed., Ambrosiana, Milano, 2003, pp. 618-638.
Candau J., 2000, Mémoire et experiences olfactives: anthropologie d’un savoir-faire sensoriel, PUF, Paris.
Candau J., 2001, De la ténacité des souvenirs olfactifs, «La Recherche», special édition La mémoire et l’oubli, july-august.
Candau, J., 2004, L’odeur médiane du couvre-lit de tante Léonie, «Voir», n. 28-29, pp. 72-87.
Cavalieri, R., 2009, Il naso intelligente. Che cosa ci dicono gli odori, Laterza, Roma-Bari.
Dojordjevic, J. et al., 2005, Funcional neuroimaging of odor imagery, «Neuro Image», 24, 791-801.
Doty, R.L., Shaman, P., Dann, M., 1984, Development of the University of Pennsylvania smell identification test: a standardized microencapsulatedtest of olfactory function, «Physiology and Behavior», 32, pp. 489-502.
Elmes D.G., 1998, Is there an inner nose?, «Chemical Senses» 23: 443-5.
Engen T., 1982, La percezione degli odori, trad. it. Armando, Roma, 1989.
Engen T., 1987, Remembering odors and their names, «American Scientist», 75: 497-503.
Engen T., Ross B., 1973, Long term memory for odors with and without verbal descriptions, «Journal of Experimental Psychology», 100: 221-27.
Gottfried J.A. et al., 2004, Remembrance of odors past. Human olfactory cortex in cross-modal recognition memory, «Neuron», 42, 4: 687-695.
Harper R. et al., 1968, Odour description and odour classification, J.& A. Churchill, LTD, London.
Herz R.S, Engen T., 1996, Odor memory: review and analysis, «Psychonomic Bulletin and Review», 3: 300-313.
Herz, R.S., Eich, E., 1995, Commentary and Envoi, in F.R. Schab, R.G. Crowder (eds.), Memory for odors, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey , pp.159-175.
Holley A., 1999, Éloge de l’odorat, Éd. Odile Jacob, Paris.
Holley A., 2002, Cognitive aspects of olfaction in perfumery, in Rouby et al. (éds.), 2002, pp. 16- 26.
Issanchou S. et al., 2002, Testing odor memory: incidental versus intentional learning, implicit versus explicit memory, in Rouby et al. (eds.), 2002, pp. 211-230.
Jehel C. et al., 1997, Role of verbal encoding in short term and long term odor recognition, «Perception and Psychophysics», 59: 100-110.
Kant I., 1798, Antropologia dal punto di vista pragmatico, trad. it. in Scritti morali, UTET, Torino, 1970, pp. 535-757.
Keller H., 1908, Il mondo in cui vivo, trad. it. Fratelli Bocca Ed., Milano, 1944.
Kerr M.A., Belluscio L., 2006, Olfactory experience accelerates glomerular refinement in the mammalian olfactory bulb, «Nature Neuroscience», 9: 484-6.
Lawless H., Engen T., 1977, Association to odors: interference, mnemonics, and verbal labeling, «Journal of Experimental Psychology, Human Learning and Memory», 3: 52-59.
Le Guérer A., 2004, La logica degli odori e il profumo del futuro, «Il Sole-24 Ore», 17 ott., 287: 18.
Lehrner J. et al. 1999, Different forms of human odor memory: a developmental study, «Neuroscience Letters», 272: 17-20.
Lehrner J., Walla P., 2002, Development of odor naming and odor memory from childhood to young adulthood, in Rouby et al. (eds.), 2002, pp. 278-289.
Lyman B., McDaniel M., 1986, Effect of encoding strategies on Long-term memory for odours, «Quarterly Journal of Experimental Psychology» 34 A: 753-765.
Lyman B., McDaniel M., 1990, Memory for odors and odor names: modalities of elaboration and imagery, «Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition», 16: 656-664.
Marlier L., Schaal B., 1997, Familiarité et discrimination olfactive chez les nouveau-né: influence différentielle du mode d’alimentation?, «Enfance», 1: 47-61.
Paivio A., 1986, Imagery and verbal processes, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.
Proust M., 1913, Alla ricerca del tempo perduto, vol. I, Dalla parte di Swann, trad. it. BUR, Milano, 1985.
Richardson J., Zucco G., 1989, Cognition and Olfaction: a review, «Psychological Bulletin», 105: 352-360.
Roncato S., Zucco G., 1993, Memoria olfattiva, in I labirinti della memoria, il Mulino, Bologna, pp. 119-136.
Rouby C. et al., 1997, Connaissance et reconnaissance d’une série olfactive chez l’enfant, «Enfance», 1: 152-171.
Rouby C. et al., eds., 2002, Olfaction, taste and cognition, Cambridge University Press, Cambridge.
Rouby C., Sicard G., 1997, Des catégories d’odeurs?, in Catégorisation et cognition: de la perception au discours, Paris, Kimé, pp. 59-81.
Schaal B. et al., 1998, Olfactory function in the human fetus: evidence from selective neonatal responsiveness to the odor of amniotic fluid, «Behavioral Neurosciences», 112: 1-12.
Schaal B. et al., 2002, Olfactory cognition at the start of life: the perinatal shaping of selective odor responsiveness, in Rouby et al. (eds.), 2002, pp. 421-440.
Schaal B., Hertling E., 1981-2000, Nuovo-nato, nuovo-naso? Olfatto e sviluppo precoce, in E. Herbinet, M.C. Busnel (éds.), 1981-2000, L’alba dei sensi. Le percezioni sensoriali del feto e del neonato, trad. it. Cantagalli Ed., Siena, 2000, pp. 359-374.
Schab F.R, Cain W.S, 1991, Memory for odors, in D.G. Laing et al., 1991, The human Sense of Smell, Springer-Verlag, Berlin, pp. 217-240.
Schab F.R, Crowder R.G., eds., 1995, Memory for odors, L. Erlbaum, Hillsdale, N.J.
Schab F.R., 1991, Odor memory: taking stock, «Psychological Bulletin», 2: 242-251.
Stevenson, R.J., Case, T.I., 2005, Olfactory imagery: A review of its phenomenological, experimental and theoretical bases, «Psychonomic Bulletin & Review», 12 (2): 244-264.
Vroon P. et al., 1994, Il seduttore segreto. Psicologia dell’olfatto, trad. it. Editori Riuniti, Roma, 2003.
Zucco G., 1988, Il sistema olfattivo: aspetti fisiologici, neuropsicologici e cognitivi, Cleup, Padova.
Zucco G., 2000, Olfatto: unicità di un senso, in AA.VV., Le tattiche dei sensi, Manifestolibri,
Roma, pp. 57-72.
Zucco, G., 2007, Odor memory: the unique nature of a memory system, in M. Plümacher, P. Halz
(eds.), Speaking of colors and odors, J. Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, pp. 155-165.